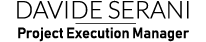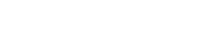Intervista a Pietro Ferraris, imprenditore e startup advisor
Dopo il confronto con Flavio Angiolillo sul metodo per creare una o più imprese e tenerne saldamente le redini, questo ciclo di interviste continua con la testimonianza di Pietro Ferraris. La nostra conversazione ha affrontato a tutto tondo il tema delle startup, che in questo momento è estremamente popolare ma è anche oggetto di malintesi e falsi miti. Pietro mi è sembrato il professionista più adatto per mettere alcuni punti fermi: come si distingue una startup valida? Per una startup, cosa significa “execution”? Come si mantiene il focus sull’obiettivo finale?
Al termine dell’intervista, ho sintetizzato alcune lezioni di execution che possiamo applicare tanto alle startup, quanto alle imprese in senso più vasto.
Di cosa ti occupi in questo momento? Elenca brevemente i passaggi principali della tua carriera.
Attualmente lavoro soprattutto per un progetto della Fondazione Golinelli di Bologna, che si occupa di educazione da tre decenni e un paio d’anni fa ha creato un acceleratore d’impresa, chiamando me come responsabile. Mi occupo di mettere assieme i contenuti, le risorse, definire la strategia di investimento e l’erogazione dei fondi sulle startup. L’acceleratore lavora in ambito Life Science, il che significa biotech, pharma, medical devices. Facciamo un bando all’anno, stanziando un milione di euro divisi in tranche a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi. Insomma, dal lunedì al giovedì lavoro gomito a gomito con dieci startup e le aiuto a crescere.
Fino a poco tempo fa ho collaborato con un fondo d’investimento di Milano sul processo di Deal Flow, cioè di selezione delle startup su cui investire. Inoltre collaboro come Advisor Senior con un paio di startup che mi piacciono a titolo personale.
Sono rimasto nel mondo delle startup dopo aver fondato due aziende (la prima in Italia tra il 2006 e il 2011, la seconda negli Usa tra il 2012 e il 2015) che mi hanno permesso di imparare un po’ di cose. La seconda, in particolare, è andata abbastanza bene: è partita in Italia e dopo breve tempo si è trasferita negli Usa, dove è cresciuta, ha raccolto capitali e nel 2015 è stata acquisita da una multinazionale svizzera.
Questo mi ha portato a voler fare “gift back”, cioè restituire parte di ciò che ho imparato spostandomi dall’altra parte della barricata. Per riassumere, aiuto le startup in partenza tramite l’acceleratore, il fondo e a titolo privato.
Sia in Fondazione Golinelli che nel Fondo si passa per uno step fondamentale: quello di vagliare le varie idee per scegliere il progetto da sviluppare. Su quali driver ti basi per procedere?
Come dicevo, dopo una formazione accademica e lavorativa incentrata sul digital, dal 2017 in poi mi sono dedicato all’healthcare con Fondazione Golinelli. I due mondi che conosco quindi sono molto diversi, ma hanno due fattori in comune:
- Il team conta tantissimo. Sembra una banalità, ma investire in startup significa investire in persone. Una frase che amo dire (anzi ripetere, perché non è mia) è che un ottimo team con un pessimo prodotto può fare i cambiamenti giusti, arrivare a mercato e avere successo; un pessimo team con un ottimo prodotto, al contrario, è destinato sicuramente al fallimento. Un ottimo team è costituito da persone motivate, dotate di competenze trasversali, capaci di fare l’execution della loro idea e resilienti. Quest’ultima caratteristica è rara ma può fare la differenza; se tante startup muoiono è anche perché, quando arrivano i momenti duri, qualcuno getta la spugna. Tanti partono con la convinzione che dall’avere una buona idea ad avere uno stipendio pessimo sei mesi, invece a volte servono due o tre anni.
- Fondamentale e trasversale è anche la dimensione e la competitività del mercato. Mi capita di vedere progetti ottimi, belli, che scaldano il cuore, ma hanno mercati di riferimento troppo piccoli o saturi. Ciò significa che la barriera d’ingresso è estremamente alta e l’investimento risulta rischioso, se non impossibile. Se un progetto per arrivare a mercato ha bisogno di 2 milioni di euro ma l’intero settore vale 50 milioni, per un investitore (che in media vuole un ritorno di 10x) diventa impossibile finanziarlo.
Nel digital i tempi per il lancio sono molto più rapidi, perché volendo puoi sviluppare un sito o un’app in sei mesi, ma diventa molto più difficile conquistare gli utenti e battere i competitor; insomma, tante dinamiche hanno a che fare più col mercato che col prodotto.
Nell’healthcare invece la difficoltà è proprio quella di arrivare al mercato, perché prima bisogna far fronte a uno sviluppo di prodotto estremamente complesso, fortemente legato all’aspetto regolatorio. Se sono richiesti soltanto i test sugli animali è un conto, ma i test sui pazienti umani fanno aumentare in modo esponenziale tempistiche e costi. Se si riesce a terminare tutto questo iter, è evidente che il prodotto è talmente disruptive da funzionare per forza.
Da dove si comincia e come si mantiene il focus sull’obiettivo finale?
Per convincere l’investitore sono fondamentali due fasi, che si esplicano in modi diversi a seconda del settore:
- Validation strategy. C’è una cosa che chiedo sempre agli startupper, ottenendo risposte spesso insoddisfacenti: prima di sviluppare il prodotto, hanno validato il loro mercato? In altri termini sono andati a vedere se effettivamente quel fabbisogno esiste, quanto è facile intercettare gli utenti interessati, se c’è qualcun altro che lo fa e, in tal caso, cos’hanno loro di diverso? Ecco, tutta questa parte preliminare – che tendenzialmente non costa un euro – spesso viene tralasciata.
- Go-to-market strategy. Questa seconda fase conta soprattutto nel digital, dove i tempi sono più rapidi, e corrisponde a questa domanda: “Come pensi di arrivare al mercato?”. Spesso mi sento dire frasi come “Se prendo lo 0,1% di questo mercato incasso un miliardo di euro”. Certo, ma come raggiungi quello 0,1%? Ho incontrato decine di persone che hanno sviluppato prodotti più o meno interessanti ma non hanno idea di come metterli in mano ai propri utenti. Allora forse è meglio partire dall’altra parte: prima parlare con gli utenti e trovare i canali per raggiungerli, poi procedere con il prodotto.
Quando arriva la fase di execution, chi “tira le fila”? Come interpreti il concetto di execution nel tuo settore? Come viene interpretata l’execution nelle realtà che segui?
Per come la vedo io, l’execution è la parte più pratica e consiste nel far succedere le cose necessarie per l’avvio del progetto. Essendo stato alla guida di due startup, posso dire che fino a un massimo di 15 dipendenti serve un Ceo che tiri le fila, perché è lui ad avere visibilità su tutti gli ambiti dell’azienda. È lui a vedere come si incastrano i pezzi, che si può spendere quella quota di budget margin, che gli investitori stanno aspettando quel risultato, che i competitor stanno facendo determinate cose.
Nelle aziende più grandi queste dinamiche cambiano. Per un periodo sono stato il responsabile della strategia mobile di Lastminute.com, che all’epoca era una realtà da 2.300 persone. In quel caso non ero realmente la guida, bensì il trait d’union tra il management e le varie funzioni aziendali che avevano a che fare con il mondo mobile, dagli sviluppatori fino al marketing e all’amministrazione. Avevo un mandato chiaro, cioè far sì che l’execution avvenisse nei modi e nei tempi giusti.
Tutto questo incipit per dire che occuparsi dell’execution significa anche fare cose che non ti piacciono. E questa forse è la parte più difficile. Fatto 100 il totale, hai un 30-40% di attività che sono nelle tue corde e nella tua confort zone e un altro 70% di cose di cui non vorresti occuparti, ma che fanno pur sempre parte del gioco. Se però le rimandi, in un secondo momento ti troverai a re-ingegnerizzare i prodotti o i processi perché ti renderai conto del fatto che la tua azienda non sta in piedi. Ci sono tanti tasselli da incastrare per far sì che il progetto venga messo a terra.
Assolutamente, capita anche a me. Dovendo far sì che tutti i pezzi si incastrino, entri nel merito di tanti aspetti o settori dell’azienda o del progetto che non sono nelle tue corde e dei quali inevitabilmente ti devi occupare perché portano alla realizzazione.
Questo ci porta anche a ragionare sul fatto che è fondamentale avere un tool di qualche tipo. La parola chiave, però, rimane project management: bisogna mettere in fila tutte le attività, capire come si incastrano tra di loro, definire i tempi, fare il gantt e rispettarlo. Poi si può usare Jira, Excel o Asana, poco importa.
L’altra cosa fondamentale secondo me è semplificare, soprattutto all’inizio. Un altro errore tipico delle startup è quello di voler arrivare al mercato con il prodotto perfetto. Ma questo difficilmente accadrà, tanto più perché il mercato darà inevitabilmente un riscontro e costringerà a cambiare qualche dettaglio. Bisogna rassegnarsi all’idea di iterare il processo: si parte con una versione 1.0 che permette di stabilire un primo contatto con il mondo esterno, poi lo si migliora aggiungendo attività e risorse. Probabilmente il prodotto finale sarà la versione 10.0.
Le 4 lezioni di execution management che possiamo imparare da Pietro Ferraris
Intervistando Pietro ho avuto la sensazione di dialogare con un professionista che da anni vive il significato vero del termine execution. Nella fase iniziale della sua carriera ha trasformato diverse idee di business in progetti, traghettandole fino alla fase di exit; oggi aiuta nuovi aspiranti imprenditori a generare valore dalle proprie idee. Di seguito, riprendo e commento alcuni passaggi che risultano molto vicini alla mia attività quotidiana:
- C’è un aspetto fondamentale che accomuna le startup in erba alle multinazionali iper-strutturate: qualsiasi azienda è fatta di persone. Se queste persone si limitano a eseguire passivamente il loro “compitino”, senza avere una visione chiara e completa degli obiettivi, il progetto non potrà mai realizzare il suo pieno potenziale. Il contributo di un project execution manager, quindi, consiste anche nel motivare il team di progetto, responsabilizzarlo e orientarlo verso l’execution. Per trovarmi preparato a questo compito, negli ultimi anni ho dedicato parecchio tempo ed energie a perfezionare le mie soft skills, che sono il completamento ideale delle hard skills.
- Un’altra responsabilità chiave dell’execution manager è quella di maturare una visione unitaria del progetto. Solo se ho di fronte a me un quadro completo posso permette di definire nei minimi dettagli ogni singola attività, assegnarla al profilo qualificato e mantenere sempre alta l’attenzione e la motivazione. Tutto questo, adattandosi alle variazioni che inevitabilmente si verificheranno nel tempo.
- Mettere a terra le attività di un progetto complesso significa incastrare uno per uno numerosi “tasselli”. Sottoscrivo quello che dice Pietro: questo impone all’execution manager di svolgere tanti compiti diversi tra loro, anche apparentemente distanti dal suo ruolo. Le opzioni sono due: cimentarsi in prima persona oppure, se il campo di competenze si allarga troppo, avere già sottomano un network di consulenti da contattare all’occorrenza.
- Tante startup falliscono perché hanno la pretesa di arrivare al mercato con il prodotto perfetto. L’imprenditore deve avere il coraggio di delimitare i confini della versione beta, proporla al mercato e analizzare i feedback; all’execution manager invece spetta il compito di implementare le dovute varianti fino a ottenere il prodotto o il servizio definitivo.